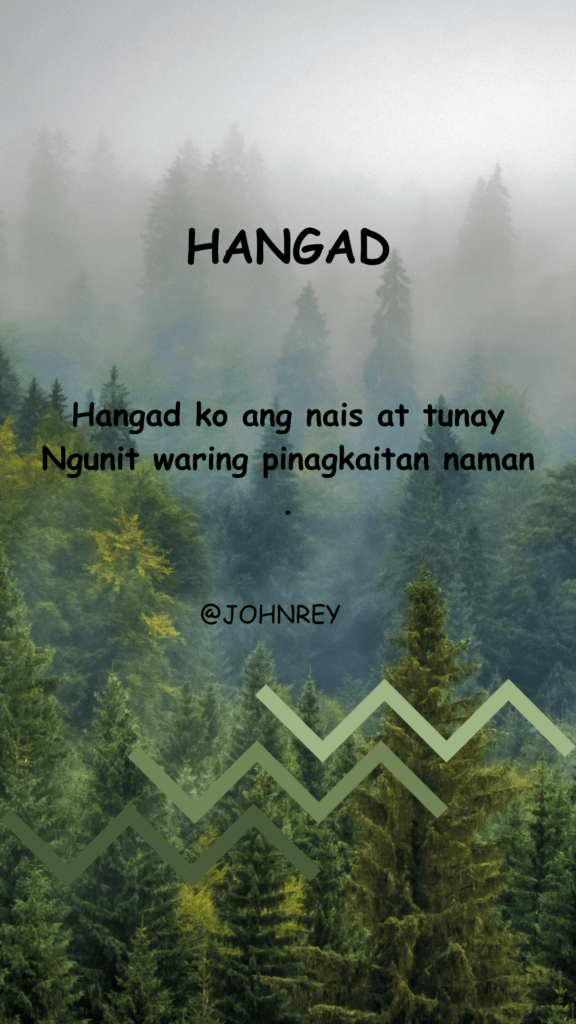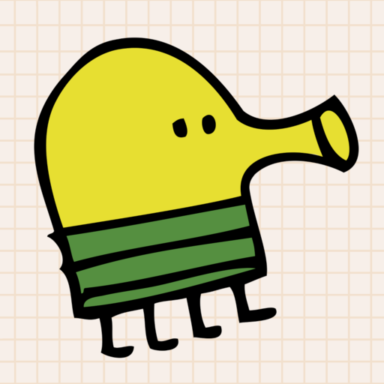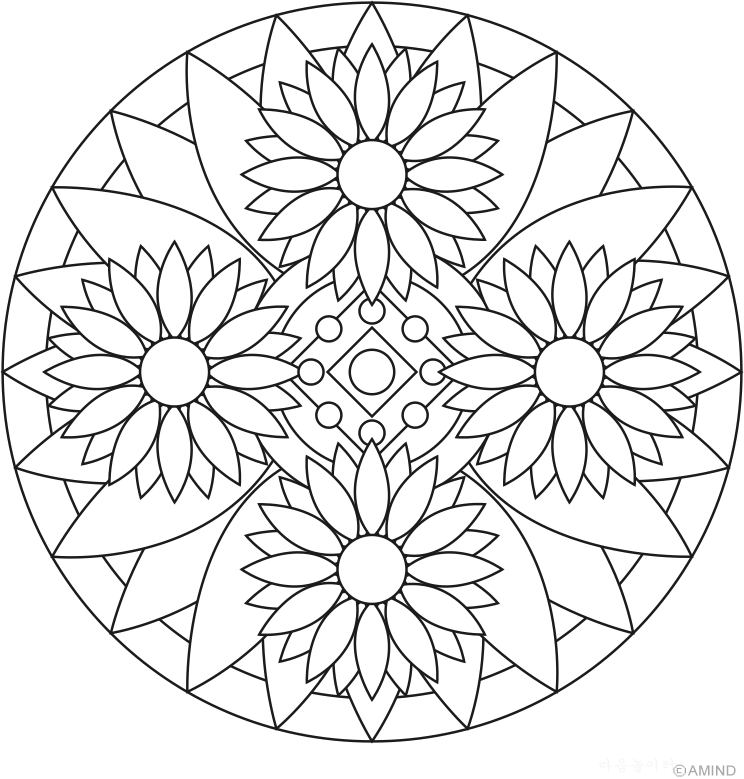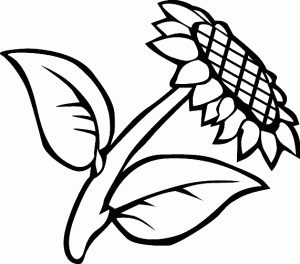Ricordiamo Ermanno Rea, scomparso il tredici settembre scorso, con un’intervista realizzata per Lo Straniero – che ringraziamo – da Alessandro Leogrande. Il pezzo risale all’ottobre 2002, all’uscita del romanzo La dismissione (Rizzoli) (fonte immagine).
Cosa ti ha portato a scrivere due libri come Mistero napoletano e La dismissione?
Ho cominciato a scrivere libri a sessant’anni. Precedentemente avevo scritto tanto, ma da giornalista. Ho lavorato per molti giornali: “l’Unità”, “Paese sera”, “Vie nuove”, “Panorama”, “il Giorno”… Ma ho sempre pensato che era necessario liberarsi dal giornalismo per cogliere la realtà. Ho sempre pensato, oggi più che ieri, che scrivere dei libri non significa inventare storie di sana pianta, non si tratta di inventare la vita. Nella grande stagione del romanzo, fino alla prima parte del Novecento, le società occidentali pativano il deficit di informazione, la carenza di notizie. In un certo senso, lo scrittore, inventando storie, riempiva questo vuoto, raccontava il mondo. Ma oggi la situazione è radicalmente diversa.
Dalla mancanza di informazione si è passati al suo esatto contrario: l’eccesso di notizie, qualcosa che ci travolge quotidianamente, un magma incandescente in cui c’è di tutto, un magma che cresce progressivamente tale da diventare oppressivo. Se in passato lo scrittore aveva il compito di inventare una realtà deficitaria, oggi al contrario ha il compito di interrompere questo flusso irreale: ha il compito di bloccare la macchina che macina la quantità di “fatti” che ci scivolano addosso.
Per me lo scrittore è colui che afferra una notizia, un fatto, dei personaggi, ed è capace di leggervi dentro, non permettendo cioè che anche quella cosa passi, come tutte le altre, sopra le nostre teste. Il caso-Ilva è uno di quegli infiniti eventi che si verificano quotidianamente e che ci vengono buttati addosso, ma che, dopo essere balenati davanti ai nostri occhi per uno o due giorni, vengono scalzati da un altro fatto. Il compito della letteratura è quello di leggere in profondità con tutti i mezzi a sua disposizione: l’analisi sociologica, l’antropologia, la storia, il giornalismo, l’invenzione, il sentimento…
I tuoi libri nascono dall’incrocio dei generi: vanno oltre il giornalismo, ma vanno anche al di là della sociologia, come se l’unica forma di adesione al reale pienamente soddisfacente fosse l’adesione all’uomo, con tutte le sue contraddizioni e i suoi nodi irrisolti. Questo in letteratura è oggi molto raro; non solo perché il giornalismo quotidianista è vincente, ma anche perché gran parte della letteratura “più realista” è risucchiata verso questo tipo di giornalismo. Quanto ha contato per te l’ idea che solo la letteratura può spiegare l’uomo, al di là di ogni altra forma di indagine?
Moltissimo. Il problema è questo: c’è la storia, ci sono i grandi eventi, c’è la nostra vita collettiva e poi ci sono i singoli soggetti, le donne e gli uomini. Se si vogliono indagare i grandi eventi si hanno a disposizione determinati strumenti di indagine: la storia, la sociologia, la politologia. Se si vuole indagare l’ uomo singolo vi sono altri strumenti, la psicologia ad esempio. Ma poi c’è l’incrocio. Se si vuole abbracciare in uno sguardo unico l’uomo sullo sfondo della storia o della società, lo strumento è la letteratura. La letteratura che prescinde dalla società e dalla storia, l’intimismo che si fa romanzo intorno al proprio ombelico non mi interessa. Nella mia vita il pubblico e il privato si sono sempre intrecciati e fusi. Non mi sono mai sentito un uomo e basta, una monade isolata.
Tutte le vicende che ho vissuto le ho vissute all’interno di questo rapporto, in una prospettiva che fondeva la mia vita dentro la vita degli altri. Io penso che la letteratura migliore, almeno quella che più mi appassiona, è quella che riesce a fare tutto questo: collocare la dimensione umana dell’individuo dentro un contesto sociale e politico molto forte. E credo che per la letteratura e per il romanzo questo sia ancora vero, nonostante si sia affermata una letteratura molto autoreferenziale.
Quando parli di contesto sociale e politico forte, penso che nei tuoi libri emerge uno sguardo sulla società e sulla politica “dopo l’ideologia”. Non mi riferisco solo a Mistero napoletano e alla cappa asfittica dello stalinismo meridionale che tu descrivi, ma anche a La dismissione: la fabbrica e la comunità che intorno a essa si è creata sono scrutate a fondo, ma l’ideologia della fabbrica e l’operaismo sono assenti.
Il nodo centrale è il rapporto tra la fabbrica e la città, perché è dentro questo rapporto che ci sono le risposte a tutte queste domande. Perché un libro sull’Ilva? La dismissione può essere letta in vari modi. Innanzitutto è la storia di un uomo che viene assunto a vent’anni e che cresce all’ombra della fabbrica. È ambizioso, vuole affermarsi, studia sui carri-ponte di notte perché vuole andare avanti e quando è diventato una sorta di dominus dell’impianto, quando ha raggiunto parte di ciò che aspirava, si sente dire che l’Ilva chiude e che deve aiutare a smontare l’impianto che verrà interamente ricostruito in Cina. Già questo legittima il romanzo, un disegno letterariamente forte.
Ma se allarghiamo il campo di osservazione, ci accorgiamo che ci sono altri motivi, e in qualche modo si capisce perché questo libro va posto in relazione con il mio precedente libro su Napoli: Mistero napoletano. L’Ilva è stata un topos, una trave portante delle ragioni etiche politiche ideali che hanno dato sostanza al mio impegno di militante, e a quello di tutta la mia generazione, negli anni cinquanta.
L’Ilva nasce agli albori del Novecento con l’idea di aiutare Napoli a uscire dalle secche del proprio sottosviluppo. Attraverso il lavoro Napoli avrebbe guadagnato quella condizione di metropoli europea che per tanti versi aveva già raggiunto, ma che per tanti altri versi non aveva ancora raggiunto. Da che mondo è mondo, noi sappiamo che la storia della modernizzazione passa attraverso la rivoluzione industriale, che ci piaccia o non ci piaccia. L’Occidente si era modernizzato attraverso la rivoluzione industriale ed era questo il sogno che si presentava anche alle porte di Napoli.
Ho sempre trovato di grande interesse la storia che precede la nascita dell’Ilva. Alla fine dell’Ottocento a Napoli si era creato un gruppo di potere molto forte intorno a tre uomini: il sindaco Summonte, il direttore del “Mattino”, Scarfoglio, e, su tutti, l’onorevole Casales. Un gruppo di giovani socialisti diede vita a un giornaletto che si chiamava “La propaganda” e denunciò apertamente tutte le malefatte e le camorre della gestione del potere cittadino, facendo nomi e cognomi e accusando pesantemente Casales. Questi fu costretto a querelare i ragazzi e tutti pensavano che, in un’aula di tribunale, sarebbero stati condannati, nessuno avrebbe mai pensato a una sentenza favorevole ai giovani socialisti.
Ma è proprio quello che successe e fu uno scandalo in tutta Italia. Casales fu costretto a dimettersi e il governo, che fino a quel momento era rimasto alla finestra, è costretto a fare qualcosa e diede vita all’Inchiesta Saredo. L’inchiesta parlamentare analizzò minutamente tutte le amministrazioni comunali che si erano succedute a Napoli dal 1860 fino alla fine del secolo, facendo luce sulla natura del malgoverno cittadino. In un tale contesto, Francesco Saverio Nitti, che aveva sempre sostenuto l’industrializzazione e che per questo era stato sempre contrasto da Scarfoglio (il quale lo accusava di inseguire la “chimera industrialista”, sostenendo che Napoli poteva benissimo svilupparsi con il turismo e l’agricoltura), riuscì a imporre le leggi speciali per la città.
Il discorso di Nitti era molto pragmatico: poiché la borghesia nazionale aveva bisogno di un’acciaieria (anche per le proprie mire coloniali), la si doveva fare a Napoli: questo avrebbe almeno permesso alla città di risollevarsi. La nascita dell’Ilva è da subito un’utopia salvifica per la città.
Alla fine della seconda guerra mondiale il mito nittiano diventò automaticamente il nostro mito. Il nostro meridionalismo si nutriva di questo. Il sogno del socialismo e della rivoluzione non era in cima ai nostri pensieri: in realtà la vera battaglia era la modernizzazione della città. E saranno state queste, poi, le posizioni di Amendola e dell’amendolismo. Il nostro sogno era quella di vedere Napoli risorgere dalle ceneri del sottosviluppo e l’Ilva sarebbe servita a tutto questo.
Ci dicevamo: sì, è vero, la fabbrica occuperà un luogo bellissimo e prima o poi andrà via, ma non prima di essere entrata nel vicolo e di averlo bonificato. Ma non prima di aver creato lavoro, non prima di averci liberato dal sottosviluppo. C’è un libro molto bello di Raffaele La Capria, L’armonia perduta. Questo libro parla di città dalla storia incompleta, come se a un certo punto la storia di queste città si fosse bloccata, fermata. La Capria parla di Napoli, Trieste… Sono le città che non sono riuscite ad avere quell’approdo verso la modernità che invece ha caratterizzato tutte le grandi metropoli europee. Napoli è una città dalla storia incompleta, paralizzata. Noi sognavamo che questo processo si rimettesse in moto e arrivasse alle sue conseguenze. L’Ilva materializzava questo sogno.
E quando decenni e decenni dopo la fabbrica è stata chiusa, in me è scattata una molla: quella di fare un inventario delle tante speranze, dei tanti sogni, di tutte le nostre illusioni. Ma il bilancio non è positivo, il destino di Napoli non è mutato. Non voglio dire che la presenza dell’Ilva non abbia portato a niente. La fabbrica ha aiutato ad accrescere la coscienza civile della città, è stata un fattore di democrazia enorme, però evidentemente non è servita a far scattare quella molla che noi pensavamo dovesse scattare. La fabbrica non ha fatto di Napoli una città risolta.
L’Ilva doveva entrare nel vicolo per bonificarlo, però il vicolo è entrato nell’Ilva e l’ha inquinata, così dici nel libro. La scelta dell’industrializzazione non solo era motivata dall’obiettivo della modernizzazione, ma anche da quello della creazione di una classe operaia meridionale. Però il vicolo è rimasto, mentre l’Ilva è stata dismessa. La storia del Pci meridionale è attraversata dalla scelta di questa strada, dalla sua mancata realizzazione e dalle sue conseguenze. Forse il Partito comunista, a Napoli e in tutto il sud, non ha mai saputo risolvere il proprio rapporto con il vicolo e con il sottoproletariato, con il proletariato marginale, probabilmente con quegli strati sociali che erano al di là della fabbrica e che erano “molto di più” della fabbrica.
Io credo che la sinistra abbia condotto una battaglia importante, anche se con dei limiti e con degli errori. Il vicolo è stato sempre una preoccupazione e un motivo di impegno. Però va anche detto che il vicolo non era, e non è, una piaga risolvibile solo sul piano dell’impegno politico, dell’impegno etico. Il vicolo è un intreccio molto complesso. Per me il vicolo è metafora di una vasta fascia sociale che sta tra l’illegalità più spinta, la semi-legalità, la fame, la povertà e un benessere discutibile perché frutto di criminalità organizzata. Ma questo non è un problema che si risolve sul piano dell’iniziativa politica pura e semplice.
Innanzitutto occorreva creare lavoro e favorire progetti urbanistici di un certo tipo. L’idea di bonificare il vicolo in senso puramente etico non credo abbia mai convinto nessuno. Quando adotto la metafora della “fabbrica che bonifica il vicolo” non mi riferisco a un elemento puramente etico. È chiaro che quando l’operaio è entrato nel vicolo, ha portato l’esempio del lavoro, dell’onestà e del rigore, ma, allo stesso tempo, intendo questo: “la fabbrica entra nel vicolo” nel senso che il vicolo diventa operaio. La metafora va capita non nel senso moralistico ma nel senso economico-sociale. La proletarizzazione era possibile solo con l’occupazione: era il lavoro il punto centrale. Io sono stato critico verso tante posizioni del Pci, però va riconosciuto che il Partito comunista ha capito da subito che la risoluzione dei “problemi del vicolo” non era una questione missionaria, ma era una questione economica.
La dismissione dell’Ilva mette in crisi un’intera comunità. La figura più tragica del tuo libro è quella di Marcella, la ragazza di Bagnoli senza speranza alcuna che si lascia morire. Cosa ha lasciato sul campo la chiusura della fabbrica?
Dismissione è per me una parola molto forte. La dismissione sembra allungare la propria ombra su tutto un passato, senza però che al contempo venga disegnato un futuro o addirittura un presente. Oggi a Napoli mi riesce difficile intravedere delle prospettive, capire da che parte va la città. Ma è evidente che tutti gli indicatori sociali ed economici ci disegnano una città dissestata, in discesa dalla maggior parte dei punti di vista. Alla dismissione non si oppone niente, solo alcune chimere. Prima c’era il mito della proletarizzazione del vicolo. Ma oggi cosa dovremmo dire: che il computer entra nel vicolo per bonificarlo? Che la soluzione è la terziarizzazione del vicolo? Mi sembra totalmente improbabile.
Per quanto riguarda Bagnoli, poi, l’assenza di prospettive è ancora più drammatica. Questa è la vera tragedia del libro. Che l’Ilva dovesse prima o poi scomparire era nella logica delle cose, nella testa di tutti, ma che avvenisse in questo modo in pochi se lo aspettavano. La fabbrica è stata dismessa senza predisporre un domani plausibile per tutte le Marcelle.
Che cosa è successo esattamente? La decisione di chiudere l’Ilva viene presa tra l’87 e l’89. La direzione decide di assegnare tutti i beni dell’Ilva a due società diverse: Steelworker e Cimimontubi. Quest’ultima assume la proprietà di tutti i suoli, l’altra diventa proprietaria di parte degli impianti e assume la funzione di venditrice di tutto il patrimonio. La testimonianza dell’ultimo direttore messa nel libro parla di ragioni innominabili per le quali la fabbrica viene chiusa: la fabbrica non viene chiusa in nome del paesaggio, né per i limiti dell’evoluzione produttiva, la fabbrica viene chiusa perché è il momento giusto per fare un colpo di mano e possibilmente speculare sui suoli. Io sono d’accordo che la fabbrica dovesse essere chiusa, ma non in questo modo. È stata un’operazione di selvaggia razzia dei suoli, l’obiettivo era quello di speculare, di far arrivare i palazzoni fino al mare. Tutto questo è presente nel libro, disseminato nei vari capitoli.
La chiusura dell’Ilva non è stata una vittoria per l’ambientalismo. La fabbrica, in fondo, era un tappo messo su quel territorio. Facendone un uso corretto, fra dieci o vent’anni il territorio potrebbe essere restituito interamente ai figli e ai nipoti di Bagnoli, ma dubito che questo avverrà. Il golfo di Napoli è stato occupato da torrenti di cemento, ma chi lo libererà da questa usurpazione, da questo massacro ininterrotto? Quale dismissione ci sarà per le costruzione selvagge? Non credo ci sarà mai. Ma di questo nessuno parla, mentre parliamo tutti dell’Ilva.
L’Ilva, il massimo esempio di industria pesante e di stato, di fabbrica fordista impiantata al sud, ha creato un uomo-Ilva, una comunità-Ilva, una città-Ilva, dei ritmi-Ilva: questa è una parte di storia del sud, indipendentemente dalle differenze regionali e geografiche. È stato così a Bagnoli e a Taranto, è stato così con la chimica a Brindisi, a Gela, a Porto Torres. Non è stata la crisi dell’acciaio a decretare la chiusura dell’Ilva, ma lo sfaldamento della Prima repubblica e il declino del sistema delle partecipazioni statali. Ma la fine dell’industria di stato (e nel senso della dismissione e nel senso delle privatizzazioni, condotte frettolosamente e in favore dei peggiori e rampanti capitani d’industria) ha creato un pantano sociale ed economico. Probabilmente queste sono oggi le zone più depresse del sud, e non parlo di degrado materiale, di fame, parlo dell’assenza di speranza e di progettazione collettiva e individuale. Pochissimi hanno analizzato cosa tutto questo ha prodotto nelle esistenze private: famiglie ridotte alla soglia della povertà, depressioni, suicidi, storie individuali senza via d’uscita… La morte silenziosa delle città industriali meridionali e cosa questo ha prodotto nella vita di migliaia di donne e di uomini sono forse il fatto più tragico degli ultimi dieci anni di storia del sud.
Quando ho delineato il personaggio di Marcella inizialmente ero indeciso, non volevo caricarlo di una eccessiva simbolicità. (Quando ho costruito il personaggio avevo in mente un quadro del 1910 di Kirchner: si chiama Marcella, appunto.) Non volevo risultare eccessivo nel descrivere il funerale di Marcella come fatto corale, ma poi mi sono convinto che era necessario, perché è la chiave di lettura del libro, non è un elemento ornativo. La disperazione a Bagnoli incomincia dai giovani. La chiusura della fabbrica significa soprattutto spaesamento e disorientamento e le conseguenze di quella soluzione improvvisata sono ricadute soprattutto sui giovani.
Prima a Bagnoli i ragazzi sapevano già il loro destino: il loro orizzonte era la fabbrica e la fabbrica li assumeva; i figli degli operai erano già mezzi operai. In tutti i mesi che ho trascorso a Bagnoli ho constatato che il vero grande dramma degli ex-operai sono i figli, la preoccupazione per il loro futuro. Da una parte c’è la sconfitta esistenziale di perdere il lavoro a quarant’anni, e dall’altra l’angoscia per i figli. Ma questo è anche il dramma di tutta Napoli. La notte, tra piazza Dante e piazza Carità, mi capita di vedere frotte di ragazzi in motorino e di chiedermi: dove si guadagnano da vivere? dove guadagnano tutto quello che spendono? Non è un giudizio moralista il mio, capisci subito che nella maggior parte dei casi è gente che non lavora.
Alcuni hanno detto che scegliendo il personaggio di Bonocore hai scritto la storia di un crumiro, di uno che si vende.
Questo non è vero, Bonocore non è un crumiro. A ogni modo non bisogna perdere di vista la dimensione del romanzo: il personaggio per metà appartiene alla realtà, per metà alla mia invenzione. Non volevo creare un personaggio mitico. Ce ne sono pure, certo, ma a me non interessava tanto quest’aspetto. Ho sempre creduto che potesse rappresentarsi meglio la realtà non attraverso l’operaio mitologico, l’operaio per antonomasia, ma attraverso un operaio particolare. In Bonocore mi interessava soprattutto far emergere l’attaccamento al lavoro. Sottolineare che l’attaccamento al lavoro fosse di una forza tale da superare tutto il resto. Quella che emerge non è una diserzione, un tradimento dei compagni, ma una visione mitizzata del lavoro e del proprio rapporto con la macchina. E ho voluto far crescere questo aspetto fino all’esasperazione, perché era quello che più mi interessava.
Questo operaio non è esistito realmente? Io ho scritto un romanzo, non volevo essere sociologicamente corretto, ma letterariamente e umanamente corretto. E Bonocore meglio di altri tipi di operai mi ha permesso di rappresentare il rapporto fra un uomo complesso, la fabbrica e la città. Bonocore è un uomo che si dice: “Io smonterò l’impianto al meglio delle mie capacità. Questo sarà il mio capolavoro, la mia uscita di scena”. Perché avrei dovuto rappresentare necessariamente il mondo della fabbrica in un altro modo? Volevo creare un individuo un po’ antipatico, perché avrei dovuto farne un santino? Un santino non avrebbe convinto neanche me. Bonocore è un uomo, con contraddizioni e vigliaccherie. Se è crumiro, è crumiro soprattutto con la moglie e con Marcella, cioè fuori dalla fabbrica, nella vita.
Che rapporto hai avuto con la “letteratura operaia”, con Volponi, Ottieri, eccetera?
Sono un amante di Volponi. Ma sinceramente non c’è un rapporto diretto con i miei libri. Provo a muovermi con le mie gambe. Questi libri nascono sulla base di un percorso molto personale: vado nel posto di cui voglio scrivere, ci sto dei mesi e provo a mescolare personaggi e situazioni. Quando creo un romanzo, non seguo modelli. Oltretutto ho una memoria di una fragilità spaventosa, ricordo molto poco anche libri che ho amato moltissimo.
Napoli è una città dismessa, però è stata amministrata da due giunte Bassolino per un periodo abbastanza lungo negli anni novanta. In qualche modo la Napoli di Bassolino attraversa i tuoi libri. Nel diario di Mistero napoletano sono raccontate le elezioni del ’93 che portano Bassolino al governo della città; La dismissione, invece, quasi coincide con le sue dimissioni da sindaco.
Io penso che l’ammistrazione di Bassolino sia stata un evento molto positivo per la città. Bassolino è arrivato in un momento propizio ed è stato anche fortunato. Le mie tesi in Mistero napoletano erano queste: Napoli è una città la cui storia è stata paralizzata dalla Guerra fredda ed è proprio la caduta del Muro di Berlino a liberare la città dai suoi fantasmi e dalle sue cappe di piombo, dall’ombrello della Nato sotto il quale avveniva di tutto e nulla poteva essere spostato. Bassolino è arrivato nel momento in cui questa cappa si è rotta e la storia della città poteva ricominciare. I primi tempi dell’amministrazione bassoliniana mi sembrano molto buoni. Ma poi anche lui ha commesso degli errori. Il più grave, e credo che ne sia diventato consapevole, è stato quello di andare a Roma, accettando di diventare ministro, interrompendo quel processo nuovo e creando in città una forte delusione.
Quando poi è tornato, probabilmente quell’errore non si poteva più ricucire. Io ho stima dell’uomo, anche se è fortemente inserito dentro le logiche e i rapporti di forza della coalizione di centrosinistra, della quale subisce tutte le contraddizioni. Ma qui non parliamo più di Bassolino, ma delle difficoltà della politica e della crisi del centrosinistra in Italia! Però, se dovessi fare una valutazione realistica delle forze in campo oggi nella sinistra italiana, non potrei non dire che è un personaggio chiave, insieme a Cofferati e a pochi altri.
È più facile scrivere di Napoli vivendo lontano da Napoli?
Penso di sì. La distanza è necessaria. E credo che questo sia un fatto generale, che non riguarda solo Napoli. La distanza permette di avere uno sguardo più creativo, meno travolto dalle contingenze. Da parte mia poi, è una risposta obbligata: non si tratta solo di distanza geografica, ma soprattutto di distanza temporale. Ci ho messo molto prima di stabilire un rapporto letterario con la città. La distanza è una mediazione intellettuale, frappone fra sé e le passioni un diaframma. Questo diaframma purifica, allontana i detriti, non è mai deviante.
L'articolo La fabbrica e il vicolo. Ricordando Ermanno Rea proviene da minima&moralia.